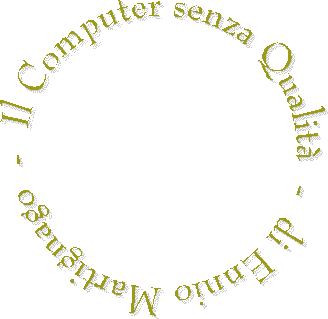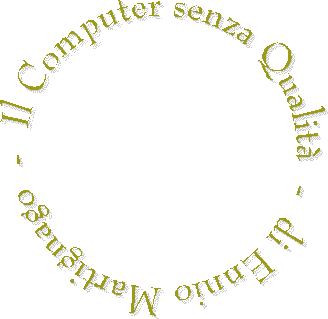Mi compro il computer
Manuale di guerriglia info-neurinica
di Ennio Martignago
Descrizione
È frequente che chi odia il computer sotto sotto pensi che “quella cosa
là” sia un po’ un “qualcuno”. Questo sostanzialmente perché l’uomo tende
a personaliz-zare le insidie della vita immaginando che obbediscano a qualche logica
propria e per maledirle meglio. Il computer poi a questo gioco si presta benissimo,
in quanto in fondo pensa, interagisce con la nostra mente con dei paleo-comportamenti
basati su degli schemi logici: un po’ come l’uomo. Talora l’uomo pensa: «Quello
lì è migliore di me! Si è accorto che non sono in grado di cavarmela
con lui e così mi fa sfigurare, trattandomi da idiota. E’ possibile che io debba
farmi maltrattare da una macchi-na. Perché mai dovrei comprare un simile mostro?».
Capita così che lo studente, come pure lo studioso, si compri un computer per
riuscire prima e meglio nel proprio compito e invece finisca per rinunciare anche
al compito, umiliato dalla sconfitta subita ad opera della macchina.
Strategie
• Accettare che “egli” sia un “qualcuno”. A questo punto amarlo e farsi insegnare
da lui la logica e cercare di insegnare a lui la vita.
• Trattarlo come un “qualcuno” di stupido e rigido e usarlo il meno possi-bile.
• Divertirsi con “lui” a inventarne un uso del tutto originale, anche se po-trebbe
sembrare poco ortodosso, o addirittura poco corretto.
Corollario
Per superare il blocco da personal-fobia bisogna imparare a mettersi in rela-zione
con il computer più che con l’oggetto di lavoro. Questo comporta che la mo-tivazione
ad apprendere e a fare è rivolta molto più alla macchina che ai fini per
cui sembrava preposta. Uno sforzo eccessivo per apprendere l’uso della macchina e
dei suoi programmi, per imparare a fare qualcosa, per fare di più, per vincere
la competizione con il vicino di casa o con la fidanzata, per riuscire ad essere
origina-li.... riduce l’investimento sui contenuti, in favore di una dimensione che,
in questo modo, per la prima volta nella storia, rende automatiche le priorità,
sollevando il sin-golo dall’angoscia delle scelte. La forma dello strumento
è il motore del processo.
Strategie del corollario
• Godersi il gioco pensando che “viaggiare è sempre meglio che arriva-re”.
• Usare solo le funzioni di digitazione, il salva, l’apri e lo stampa.
• Separare la scrittura a penna dalla stesura finale.
Controindicazioni
• Quando devi produrre qualche cosa è meglio che ti scordi le crociere.
• Usando lo strumento al minimo delle sue potenzialità non puoi sfruttare i
vantaggi dati dall’interazione con lo strumento.
• Un tipo di computer può essere più o meno amato, ma alla fine rimane
solo un tipo di computer. Come un buon sassofonista deve far dare il meglio ad ogni
tipo di sax che usa per le sue sonorità caratteristiche, così ogni computer
dev’essere sfruttato al meglio per ciò che ha da dare. Anche in questo cam-po
la tifoseria è un limite operativo e mentale.
Interazione Autore e Simulazione
Esiste una vecchia diatriba fra i linguisti come fra gli psicologi che verte
sul ruolo che la forma ha nei confronti del comportamento. La stessa distinzione
si può fare fra il testo, inteso come un primo livello di “materializzazione”
del pensiero, e la pagi-na stampata. Che il testo sia qualche cosa di molto diverso
dalla pagina stampata è uno di quei principi ovvi che nessuno però riconosce
nella vita quotidiana. A ren-dere ancora più evidente questo principio sono
gli elaboratori di testo. Quando le differenze fra word porcessor (wordstar, wordperfect,
word...) e impaginatori (Ventura, Page Maker, X-Press...) erano più nette, anche
la differenza fra il testo co-me “ragionamento a voce alta” che l’autore fa
con se stesso con l’ausilio della penna e la pagina come espressione estetica
del messaggio da divulgare era più chiara. Nel leggere la pagina come appare
nel computer l’autore fruisce come lettore di una simulazione del prodotto
compiuto. Il suo atteggiamento mentale è quindi diverso. Quello che appare sullo
schermo, gli strumenti (il portapenne e il ta-volo di composizione) e lo stato dell’arte
del prodotto finito (la pagina stampata, il volume, la “tela”...) sono dei veri e
propri interlocutori dell’autore, che con essi intra-prende un dialogo continuativo
fatto di costanti interazioni biunivoche (numerosi feedback continui). Solo
un atto di volontà, l’imposizione della parola Fine prece-dentemente
programmata interrompe questo dialogo.
La forma cambia il contenuto e questo cambia la forma. Entrambi, poi, modifi-cano
il modo di sentire dell’autore nel momento stesso in cui crea. Come l’amore per il
suo tipo di strumento porta il musicista a prediligere uno stile musicale piuttosto
di un altro, lo stesso può capitare per qualsiasi autore che usi un computer
anziché un altro, un certo tipo di software anziché un altro.
Computer & Carta
Descrizione
Un computer non sostituisce la carta così come la carta non sostituisce
il com-puter. l’uso dei due media non è alternativo. La valutazione dello strumento
da usa-re è di ordine sostanzialmente estetico e, solo secondariamente,
logistico; infine logi-co.
Io, ad esempio, tendo a prediligere due tipologie simili sia per la carta che per
i computer.
Per la carta scelgo:
1) il tipo molto grande per operazioni complesse o soggette a disordine e esercizi
di creatività (perché mai sparpagliare tante idee in tanti fogliettini,
invece di fare una gigantografia con freccette, sentierini, disegnini...?); oppure
2) quello molto piccolo: trovo che un quaderno cinese (di quelli rossi e neri o in
stoffa ricamata) del formato 15 x 10 cm. sia l’ideale; arriva dovunque, è gradevole,
eco-nomico, si può usare in mille modi, si archivia bene...
Come computer prediligo due tipi di prodotti per due diverse occasioni:
1) Un computer da tavolo molto potente, con tutte le periferiche necessarie (scanner,
rimovibili, stampanti, CD ROM...), come laboratorio, quartiere generale... Diventa
un po’ come la villa di campagna dove possiamo sbizzarrirci con lo spazio e con gli
oggetti, che qui possono trovar respiro di movimento e varietà di espressione.
2) Un computer da viaggio molto leggero, molto economico, dall’interfaccia spar-tano,
ma completo; fatto per le esigenze di base e modularizzabile in qualsiasi siste-ma.
Purtroppo gli esempi sono pochi. Due non soddisfano la condizione di econo-micità:
il PDA (che a suo discapito ha anche il fatto di non essere dinamico, almeno fintanto
che i sistemi di comunicazione sono quello che sono) e il subnotebook di nuova generazione
(che, essendo carissimi, non si possono certo trasportare dovunque con la massima
non chalance). L’altro è il vecchio Quaderno Olivetti con processore NEC
80X86 compatibile. A saperlo configurare è perfetto: non consuma (le batterie
arrivano a superare le quattro ore), supporta benissimo un integrato DOS come MS
Works 3.0 e le utility di base lasciando liberi ancora circa 15 Mb per gli archivi
utente, che in effetti sono molto più di quanto serva in ambiente DOS. Difetto
principale: introvabile lui, ed introvabile qualsiasi tipo di imitazione.
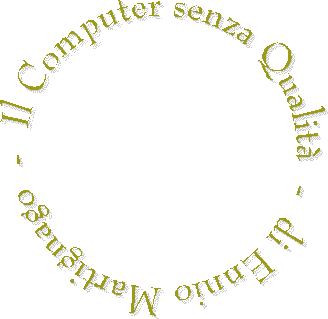
Ennio Martignago