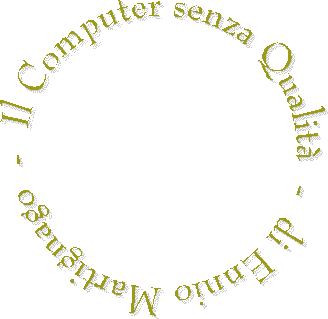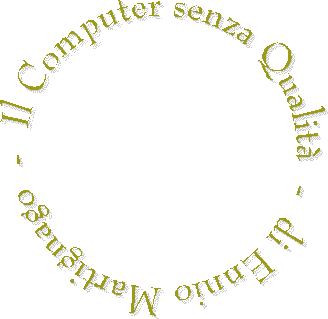
Ennio Martignago
SCRIVERE L'INFORMATICA
di Ennio Martignago
La scrittura informatica abita un territorio di confine. Nata sulla scorta dello
stile espressivo di tradizione marcatamente manualistica, veniva inizialmente letta
talvolta dagli addetti ai lavori e poi, sempre più frequentemente, dai possessori
di software copiato1.
Le esigenze di quel tipo di utenza erano quelle di avere dei manuali il più
completi, dettagliati, ancorché criptici. Poi venne la moda della rapidità
di consultazione, nata dalle necessità dellutenza preparata, quella che, sapendo
utilizzare quel genere di applicativi, aveva bisogno soltanto di sapere dove trovare
il corrispettivo dei comandi e dei linguaggi noti in un altro pacchetto e da quelle
dellutenza saltuaria, coloro, cioè che non avrebbero mai sfruttato interamente
tutte le potenzialità del prodotto, ma che cercavano solo un sostituto alla
macchina da scrivere o alla calcolatrice. Costoro, inoltre, non avevano intenzione
di investire grosse cifre per i loro limitati e specifici obiettivi. Così venne
lora degli instant book.
Accanto alla manualistica esisteva solamente la letteratura specialistica per operatori
avanzati: testi sulle reti locali o sulle generazioni dei linguaggi di programmazione,
e così via.
Improvvisamente anche il consumatore casuale, lutente domestico ha aperto le porte
di casa al computer e ai suoi programmi. A sua volta si sono diffusi a dei prezzi
proponibili programmi user friendly di buona qualità. Le riviste di informatica
sono, una alla volta, diventate meno esoteriche e meno seduttive nei confronti dei
fanatici del chip. Qualcuno sembra accorgersi che non è più sufficiente
scrivere manuali, ma che è opportuno venire incontro al desiderio di un intrattenimento
sulla materia informatica accessibile ai più.
L'idea di uninformatica facile e gradevole sembrava una bestemmia solo nel
92, ma già fra il 93 e il 94 questo genere di libri ha visto una diffusione
che ha premiato le scelte di taluni autori e case editrici, come Stanley o Apogeo.
Non mancano fra questi lavori, tuttavia, i manuali dissimulati. Quali libri possono
rientrare in questo genere e quali no, credo possa dipendere innanzitutto dallo stile
con cui sono scritti. La scrittura più adeguata per il libro semplice
è quella che sta al confine fra la narrativa e la saggistica divulgativa. La
leggerezza e la capacità di non risultare offensivi nel semplificare fino allestremo
sono le qualità migliori. Se un conoscitore di informatica e di software può
trovare piacere nel leggere in un libro le cose che già conosce a memoria, allora
quello può risultare un lavoro scritto bene, a condizione di risultare comprensibile
anche a chi non ha - quasi - mai preso contatto con un elaboratore. Si badi bene
a non sopravalutare, tuttavia le esigenze di questi lettori. Per molti leggere dinformatica
deve servire solo da pretesto per poter affermare la fondatezza delle proprie idiosincrasie:
non bisogna dimenticare che per i più il problema reale non è costituito
dal conflitto logico con il comando del programma, ma dal rigetto fisico per la tastiera
e per il suo contatto e la ricerca dei tasti. Molti degli anti-informatici sono prima
di tutto degli anti-dattilografici e ancora invidiano il figlio che sa fare le somme
con la calcolatrice trovata nel fustino del detersivo.
Quando però un libro è scritto male non ci devono essere scusanti. Un altro
fatto interessante emerso è che questo tipo di letteratura, rispetto alla precedente
manualistica, consente maggiormente lemergere di stili letterari personali, e quindi
laffermarsi di veri e propri autori, per quanto negletti dalla letteratura2.
E lo stile non può né devessere prescritto. Pertanto non sarò io a
tentarlo. Tuttavia alcune regole mi sembrano indispensabili e generalizzabili.
1) Prima di tutto, fare bene gli esempi! La comprensione si favorisce con gli esempi
e questi devono risultare organici fra loro e misurati sulle potenzialità del
lettore-tipo (target). Il che non significa che bisogna mirare a ciò
che è in grado di fare, ma solo partire da ciò che usualmente fa e chiede
di saper ripetere con altri strumenti per arrivare a ciò che non sapeva neppure
di poter fare, mostrandone la semplicità. Lesempio da costruirsi devessere possibilmente
unitario, un lavoro che attraversi tutte le parti del libro, partendo da azioni banali
e note a tutti per giungere a promuovere nel lettore lauto apprendimento. Per esempio,
per spiegare luso di elaboratori di testi sarebbe bene partire da una lettera commerciale
o un curriculum per arrivare alle macro, agli stili e allincorporazione di oggetti
individuando da necessità precise (es.: insegnare il mail merging con le macro,
prima di spiegare che esiste un comando di questo tipo già integrato, o la creazione
di un foglio intestato con lincorporazione di un bitmap) e finire lasciando aperte
delle domande che stimolino la consultazione della guida, oppure, ancora, lanciando
sfide di abilità nella personalizzazione.
2) Non dare nulla per scontato e non saltare i passaggi logici.
Troppo spesso si danno per scontate nozioni che sembrano tali per gli addetti ai
lavori, ma che per il comune parlante sono prive di senso. Pensate a quanto di anomali
e innaturali sono i concetti di campo (magari field) e di record per
una persona sana! Prima di spiegare come si fa una macro sarà bene partire
dallesigenza di automatizzare delle azioni ripetitive. Solo se lo si valuta importante,
si possono poi definire questi automatismi con il termine di macro. Prima
di spiegare come si usa un foglio elettronico bisogna far cogliere la differenza
fra questo e una calcolatrice.
3) Ricalcare le esperienze quotidiane e le frustrazioni di chi ha a che fare con
il computer. Nel fare questo, cercare di usare gli occhi del neofita, della persona
che lelaboratore lo usa saltuariamente di meno a quelli di colui che ne fa un uso
sistematico per unattività ripetitiva, e meno che mai a quelli dellinnamorato
o delladdetto ai lavori, che cala sul mondo incosciente la sua grande esperienza
e la straordinaria sensibilità maturata in tutti questi anni. Se si usa il cervello,
accettando la fatica di non usare il potere e le risorse conferite dalla cattedra,
ci si potrà stupire di quante occasioni, dallenciclopedia alla minestra di cavoli,
si possono usare per parlare di qualsiasi programma (la minestra di cavolo
dal wp allo spreadsheet fino allo storyboard o al CAD e tutti insieme, interfacciati,
linkati, impacchettati, ecc...).
Cultura informatica
Un lavoro che si sviluppa sul tema informatico deve fare i conti con delle evoluzioni
in tempi troppo rapidi per potersi consentire unelaborazione simile ad altri tipi
di testi. Molto deve rimanere incompiuto, ed un buon lavoro è spesso quello
che mette gli altri in condizione di imparare adattivamente. Non ha senso insegnare
tutto. Lidea di un futuro in perenne sviluppo della professionalità degli sviluppatori
e dei programmatori si scontra con levoluzione dellhardware e delle reti, che sta
rendendo possibile ai più luso di linguaggi di interrogazione semplici ed elastici
sul modello dellSQL in sistemi client/server. Lo stesso dicasi per documenti ed archivi.
Il concetto dei sistemi documentali ipertestuali uniforma interi sistemi informativi,
banche dati e persino biblioteche, in un unico grande documento, consultabile nello
stesso modo con cui ci si muove in un Web di Internet. Per questo la scrittura informatica
deve fare i conti con la dimensione fisiologica del cambiamento, trasformandola da
un limite ad una risorsa, e con la provvisorietà del testo che diviene il suo
più potente elemento stilistico. Provvisorietà e incompletezza (che il
lettore va a riempire) mi sembrano poter diventare il contributo più forte che
la scrittura informatica può offrire alla letteratura e allespressione (alla
poetica nel senso di Jackobson, più in generale) del nostro tempo.
Non si può tuttavia dire che i libri dedicati allinformatica semplice costituiscano
un vero e proprio rivolgimento nel testo informatico. Neppure certi testi divulgativi,
come Fare la tesi con il PC o Fare bene il manager con i computer ecc... possono
essere considerati dei passi avanti verso una vera e propria apertura ad un pensiero
ed una cultura informatica di rango. Il salto di valore lo possiamo scorgere negli
ultimi due anni, da quando personaggi non sospetti ed estranei alla cultura tecnicista
si stanno dedicando al significato sociale, psicologico, filosofico, giuridico, politico...
delle implicazioni informatiche. Questo salto coincide con lesplosione inconsulta
dalla telematica di Internet. Librerie solitamente ostiche al libro tecnico e, primo
fra tutti, a quello informatico oggi riempiono intere vetrine di volumi alcuni dei
quali assolutamente indigeribili dedicati alla madre di tutte le reti. Gente
che ha sempre avuto seri problemi a fare un foglio di stile si cimenta con protocolli
TCP/IP, driver Point to Point o Seriali, BAUD, link ipertestuali e protocolli di
trasferimento dei files.
Nessuno avrebbe immaginato che una realtà così ostica, fino a ieri costituita
di indirizzi chilometrici e di repellenti comandi UNIX, avrebbe potuto costituire
la leva che cambiava le sorti di un sapere apparentemente destinato ai santa sanctorum,
o ai postriboli, se si preferisce, di un gotha tecnocratico.
A pensarci bene, sarà proprio questa irruzione a segnare la fine dei computer
così come li concepiamo. Solo qualche mese fa mi trovai a fare questa considerazione
in una conferenza telematica nazionale suscitando diffidenza e sconcerto nei più.
Ma non ero certo Jules Verne: Apple, che da sempre precorre i tempi, oggi sta preparando
i non-computer (alcuni come Pipin, un potente computer mascherato da lettore
di videogiochi, o come il decoder per la TV interativa, sono già realtà).
Presto ci si collegherà al sistema telematico preferito senza pensare alo strumento
che si sta adottando.
Ecco allora che il discorso telematico si fonde con quello urbanistico e la netiquette
porta a riflettere sullesistenza di un'etica dellinformatica.
La tecnica e la cultura si stanno fondendo e presto la saggistica sarà pregna
di concetti informatici e luso dellinformatica darà nuovi temi e nuovi ambiti
per la conoscenza. Pensate ad esempio a come la medicina è passata da un piano
tecnico ad uno culturale con quella che Illich ha chiamato la medicalizzazione
della società e che Foucault ha ben analizzato ne La nascita della clinica
oppure rievochiamo lormai consunto esempio della nascita della stampa a caratteri
mobili. Laspetto più interessante di più di questultima non è quello
tecnico, quanto piuttosto quello connesso alla sociologia della conoscenza. Guttemberg,
che credeva sostanzialmente negli aspetti tecnici della sua invenzione, morì
pieno di debiti. Non così Manuzio che applicò la scoperta al libro. Oggi
a noi questo fatto può sembrare ovvio, tuttavia dovette sembrare un salto mortale
nellepistemologia dellepoca la serialità della produzione e della diffusione
di una cultura fino ad allora vista come patrimonio di pochi e il più delle
volte consegnata al rapporto orale a due fra discepolo e insegnante. Altrettanto
iniquo può sembrare ai più linquinamento della cultura con la tecnica informatica.
Badate bene, non sto a parlare dellinformatica come strumento, ma come sistema semantico
o come pretesto epistemologico. Un esempio di questi risvolti lo si può trovare
nei libri dedicati alla logica Fuzzy o ai discorsi sulle interfacce, per non
parlare del consunto tema della virtualità o meno della realtà. Paradossi
come il cybersex, lontano dallessere interessanti per loggetto in sé,
portano inquietudini sul rapporto fra fisica e coscienza. Un altro esempio di questa
rivoluzione lo si ritrova nella discussione su identità femminile e governo
del ciberspazio. Interessante è anche la strana questione di come viene interpretata
lappropriazione dello spazio telematico da destra e da sinistra. Come spesso
è accaduto, pur rivolgendosi a contesti e referenti diversi, il modo
con cui si cerca di appropriarsi del media non è troppo dissimile. Lo
è molto di più se confrontato con lepistemologia nomade degli hacker3, da un lato, e dallo spontaneismo dei BBS e delle reti amatoriali,
dallaltro.
Nomadismo informatico
Eccoci con questo esempio giunti a quello che amo chiamare il nomadismo informatico,
vale a dire quel rapporto spesso conflittuale che esiste in alcuni personaggi orfani
di una tradizione culturale di stampo, vuoi tecnico, vuoi accademico, che usano
linformatica e ne parlano facendo riferimento alla loro esperienza in prima persona.
Con questo pensiero nasce lidea di un ribaltamento ulteriore della scrittura informatica.
La persona e il suo computer possono fare scrivere di filosofia, in modo simile a
Jabes, che si dipingeva come luomo che viaggiava con un libro di piccolo formato
(che era un po una metafora del sé), oppure di comunicazione, damore, di politica...
La dimensione uomo-elaboratore può fare riflettere, alla Valery o quasi-buddisticamente,
al rapporto vivente con un metodo. Narrativa può nascere e avere luogo in spazi
virtuali (e i lavori di Gibson e altri sono solo i primi esempi, ancora troppo deffetto,
se confrontati con un possibile minimalismo stilistico offerto dal media).
Ciò che è ancora tutto da scoprire è la temperatura, gli spazi,
i tempi possibili per una scrittura che nasca dalla speculazione intellettuale
sul e con lo spazio e il tempo del proprio ordinateur. Oggi sembra che
questi scenari siano ancora lontani dal profilarsi ancora lontani, ma, come questo
micro universo ci insegna, ben poche delle nostre immaginazioni sono così ardite
come il divenire della realtà.
NOTE:
1) I veri coloni della diffusione dell'informatica di massa. Questa perversione ha
infatti diffuso lidea del software come oggetto di consumo, portandolo a dei prezzi
abbordabili da tutti, da dieci a venti volte inferiori a quelli di tre anni fa, a
fronte di una diffusione migliaia di volte superiore.
2) Sarebbe importante che le riviste del settore iniziassero a recensire questi testi
prima per il loro valore letterario e poi per quello tecnico, così come sarebbe
ora che alcuni di questi libri trovassero posto anche nelle pagine di periodici di
recensione libraria dai più divulgativi (come Tuttolibri) ai più
esigenti (come L'Indice).
3) Non pensiamo agli hacker sempre e solo come a dei"lullisti del secolo
telematico. In realtà vi è molto più timore per i destini della telematica
e rispetto per l'informatica fra questi ultimi che in tutta l'orbe dell'industria
elettronica e informatica. Gli hacker in fondo sono l'ultimo esempio di idealisti
romantici, solo a volte un po' balordi, del postmodernismo.